Il lavoro non è un’astrazione: non si sostanzia solo di numeri, statistiche, percentuali, leggi. Il lavoro sono le persone: carne e ossa, sudore e tragicamente sangue; è fatto delle storie personali, di famiglie, di amici; avvicendamenti presenti e aspettative future. Il lavoro non è lettera muta, ma ha una voce: che grida, che fa sentire tutta la propria vitalità, che lotta e si afferma, che testimonia il presente per un futuro che deve avanzare. La voce è quella dei lavoratori, che non tornano indietro sui propri diritti neanche per prendere la rincorsa. Ma la verità è che nessuno sa bene più cosa sia il lavoro e chi siano i lavoratori. La letteratura sul lavoro, o meglio, la letteratura della working class serve proprio a questo: ridare la parola ai lavoratori e la loro voce guardare il mondo da un altro punto di vista. In quest’ottica, la letteratura è una alternativa all’ovvietà, che porta a galla un reale che abbiamo bisogno di conoscere più a fondo. Ma, soprattutto, abbiamo bisogno della letteratura per ridare voce politica al lavoro. È questo il senso del Premio Letterario Giuseppe Di Vittorio, promosso dall’Iress Lazio insieme alla Cgil regionale e alla Fondazione Di Vittorio, che lo scorso venerdì 27 settembre è arrivato alla conclusione della sua prima edizione con la premiazione avvenuta nell’ambito della Festa del Tesseramento della Cgil di Roma e del Lazio. “Un’iniziativa sul piano culturale per il cambiamento che pone la letteratura del lavoro come un punto di ripartenza”, evidenzia il presidente dell’Iress del Lazio, Eugenio Ghignoni.
Gli autori sono tutti lavoratori, gente comune che di mestiere non usa la retorica, e sono stati premiati i progetti sì scritti meglio, ma con uno stile sincero e personale. Perché che si scriva di qualcosa che davvero stia a cuore è la via per trovare la propria voce. Due le sezioni del concorso, entrambe valutate da una giuria popolare – composta da iscritti e delegati della Cgil – e da una giuria scientifica. La prima, “Voci del lavoro”, riservata ai racconti inediti, ha premiato Chiara Grossi con il suo Tozzo di pane; il secondo classificato è Maurizio Busi con Notizie da un paese cannibale; il terzo è Cristina Pasqua che con Coincidenze si è aggiudicata la menzione speciale della giuria scientifica. I racconti dei primi tre classificati, insieme agli altri tredici selezionati dalla giuria popolare, saranno pubblicati nella collana “Workingclass” della casa editrice Alegre.
La seconda sezione, riservata a romanzi già editi, porta il nome del romanzo di Primo Levi La chiave a stella, anche se – come osserva Nunzia Penelope, che ha moderato la premiazione – purtroppo il senso di quel romanzo, un lavoro che conta, non si riflette negli scritti in concorso, piuttosto disamorati e disillusi del e dal lavoro. Ad aggiudicarsi la vittoria in questa categoria è Per giusta causa (Milieu, 144 pagine, 17,00€), romanzo di esordio di Andrea Danilo Conte, – avvocato del lavoro attivamente impegnato sui diritti sociali, cofondatore del Centro studi Diritti e Lavoro e del Centro di Iniziativa Giuridica Abd El Salam – che inaugura il genere social legal thriller in cui i temi della giustizia sociale si intrecciano con i crimini dell’ingiustizia dei padroni, l’arma più letale che ammazza la dignità dei lavoratori. E a volte, purtroppo, anche le loro vite. Le vicende che si susseguono nel romanzo – ambientato nel 2018 tra Firenze e Milano, Genova e Piacenza – sono tutti casi reali seguiti da Conte, vera voce narrante nascosto sotto la terza persona di Chiton: un avvocato del lavoro che, attraverso le storie dei suoi clienti, racconta il frammentato e spietato mondo del lavoro contemporaneo. Chiton prende il nome dalla canzone di Francesco Guccini Keaton, quel pianista che non sorrideva mai, mentre noi ci ammazzavamo di risate a vederlo là, come un parafulmine, dritto contro un cielo di guai. E infatti Chiton è un avvocato che non ride mai, che come un parafulmine difende i suoi assistiti dai mali di un mercato del lavoro sempre più deregolamentato e soffre insieme loro; sempre dalla parte degli invisibili e dei diseredati (come suggeriscono, in esergo, anche i versi di Francesco De Gregori Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai). Ed è a queste persone che Danilo Conte dedica il premio: per restituire loro voce e dignità, ma soprattutto ripararne destini. Ballerine, ricercatrici, infermieri, postini, addetti stampa, commesse, modelliste, rider, custodi di musei, portuali: Chiton li ripara dai fulmini che in un solo momento spazzano via le poche certezze che hanno. «[…] l’utopia del Rinascimento, la storia, i secoli passati a credere che l’umanità progredisce, che il futuro sarà sempre migliore del passato. E invece non è così. Le conquiste, la civiltà, la libertà non sono un dato acquisito per sempre, ci sono tornanti della Storia in cui l’umanità regredisce. In cui tutto è in salita. E portare una figlia a scuola o arrivare in un cazzo di supermercato senza vivere ogni giorno con la paura, diventa un’impresa da supereroe».
La giungla dei contratti, a volte rinnovati 108 volte, come alla pianista Gaia, per esigenza temporanea o ogni anno per 22 anni per pura formalità, come a Susanna, lei per giunta anche una finta partita Iva; le imprevedibili esigenze stagionali che per tre anni hanno portato Pasquale, operatore di call center, a lavorare con contratti di sei mesi in sei mesi dopo essere stato allontanato dal precedente lavoro perché rappresentante sindacale; subire il mobbing come la modellista Eleonora, solo perché si è opposta al sopruso del capo maschilista e violento; vivere sotto ricatto come la signora Ramirez, infermiera sudamericana che insieme alle sue colleghe pagava i lussi della caposala in cambio della stabilità lavorativa; adattarsi al clima di tensione per la paura di perdere il lavoro dando una mano alla multinazionale in difficoltà, come Giuliana, sennò tanti saluti e avanti un altro a prendere il tuo posto; fare la pipì in un sacco dell’immondizia pieno di segatura come Filippo, operatore museale assunto in appalto da una cooperativa assente che non vuole prendere altro personale. Sono solo alcune delle storie raccontate nel libro, ma tutte attraversate da un sentimento di rabbia e paura per uno sfruttamento legalizzato e senza scrupoli. La solitudine e lo smarrimento davanti a un certo mondo del lavoro che appare come una vera e propria associazione a delinquere. «Sovrintendenti pagati centinaia di migliaia di euro l’anno, seduti sugli ottovolanti delle poltrone, convinti che a chi è senza pane si possa offrire una brioche».
Chiton non è un muro su cui queste storie rimbalzano automaticamente verso le aule di tribunale, non è un mero esecutore che tratta i casi dei clienti fregandosi le mani per la parcella: Chiton vede uomini e donne, ne assorbe gli umori e le emozioni; gli entrano dentro, gli tolgono il sonno, gli alimentano una rabbia che pure non lo logora, ma piuttosto lo rendono a ogni udienza sempre più presente e combattivo. Ma anche lui è un uomo e gli si ferma il sangue quando torna a Piacenza per il processo che coinvolge trentatré operai ingiustamente licenziati dalla stessa ditta in cui lavorava Abd El Salam, l’operaio egiziano investito nel 2016 da un camion aziendale durante una mobilitazione per la stabilizzazione dei contratti. Quell’Abd El Salam che «ne aveva fatte di battaglie sindacali, ne aveva visti e organizzati di picchetti, ne aveva masticate di promesse tradite» e che è morto con la parola “sciopero” sulle labbra.
Con il suo racconto, Chiton – da cui nel corso della lettura è davvero difficile scindere la presenza di Conte, come se l’autore stesse eccedendo dalla sua penna per la propulsione di una frustrazione accumulata negli anni della sua carriera – ci fa vedere lo stato dell’arte del lavoro: il rapporto tra capitale e lavoro che si è trasformato in un meccanismo asfissiante, che stritola i suoi ingranaggi e si alimenta della ricattabilità favorita dalle riforme che hanno smantellato il sistema di garanzie dei lavoratori condannandoli a un purgatorio di precarietà che però è più simile a un inferno. «Il vero potere è una relazione di paura, di soggezione, avere in pugno altre vite senza doverne rispondere. È essere ascoltati con maggiore interesse dal magistrato perché si è brillanti. È un completo blu di ottimo taglio, un sorriso con denti bianchissimi, padroneggiare le parole giuste, pronunciarle con i toni perfetti. [Chiton] Giurò a sé stesso che contro quel potere più invisibile e più odioso, che si tramanda come nelle dinastie, che si trasferisce di generazione in generazione come un’appendice delle eredità miliardarie, avrebbe lottato per tutta la vita».
I lavoratori hanno tante facce: c’è chi è sopraffatto e chi invece la paura la tiene in cantina. Non è certo una gara a chi ha più coraggio di attraversare il campo e cercare di non saltare sulle mine, ma si tratta di una grande varietà che dà sostanza a un corpo unico. Ogni storia raccontata non è quella di un singolo, ma di una collettività che eccede il lavoro e coinvolge tutta la società civile. Come nell’ultimo capitolo, in cui Chiton/Conte ritorna a Genova, la sua città, e raggiunge i camalli in mobilitazione contro un carico di batterie per droni diretto in Yemen che dovranno stivare sulla nave in arrivo. È sulla banchina del porto che va in scena il romantico atto di un lavoro che credevamo scomparso: «All’assemblea erano più di quattrocento; oltre ai portuali che erano in prima fila, tanti professori, coi quali i camalli avevano un’antica affinità politica sin dai tempi delle manifestazioni contro la “Buona scuola” e poi studenti, anarchici, scout, preti, Emergency, tutte le associazioni pacifiste e per la difesa dei diritti umani. Genova aveva risposto». La società tutta ha risposto con un “no” non solo alla guerra, ma con un “forza” ai lavoratori che non sono pedine. Perché il buon lavoro è il destino di una buona società.
«Perché mi son rotto le palle», dice Josè a Chiton alla fine della protesta al porto, «rotto proprio le palle di chi dice che il mondo va a merda e non fa niente per cambiare le cose! Facciamo tutti grandi discorsi, riunioni, analisi raffinate, lunghe assemblee piene di parole, riusciamo anche a litigare tra noi, ma nessuno ci mette la faccia, nessuno che passa all’azione. E ora ho la possibilità di farlo, Chiton, di metterci la faccia. Un conto è andare a lavorare onestamente, un altro far parte di un ingranaggio. Mi dici cosa distinguerebbe me che carico un pezzo di arma su una nave, dal militare che aggancia un missile a un aereo? Non voglio far parte di un ingranaggio. Voglio mettere un cartello: ‘Qui non si accettano ordini’».
Il libro di Andrea Danilo Conte è necessario, adesso più che mai e fortemente per le nuove generazioni che si affacciano al mondo del lavoro. Qualcosa è già cambiato, i giovani hanno capito che da questi gangli ci si può liberare e i fenomeni del quiet quitting o delle grandi dimissioni post-covid ce lo dimostrano. Ma questa è solo una piccola percentuale, perché l’invecchiamento della popolazione lavorativa e la scarsità di capitale umano potrebbe essere un’arma nelle mani dei padroni e dello Stato per incalzare questa macelleria sociale sulla pelle dei lavoratori.
L’autore ci commuove, si vorrebbe poter abbracciare Chiton e forse piangere con lui per la rabbia; viene voglia di imbracciare la lotta e non arrendersi a un destino che non ci appartiene, che non vogliamo. Ed è urgente parlare al plurale, perché se si procede ognuno per sé si fa il gioco dell’antagonista in questo thriller senza fine.
Elettra Raffaela Melucci
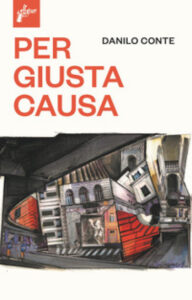
Titolo: Per giusta causa
Autore: Andrea Danilo Conte
Editore: Milieu – Collana Visionari
Anno di pubblicazione: 2023
Pagine: 144 pp.
EAN: 9791280682673
Prezzo: 17,00€


























