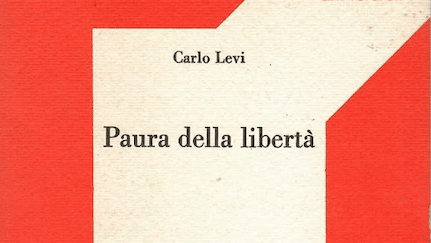Carlo Levi scrisse “Paura della libertà” tra settembre e dicembre del 1939, mentre soggiornava a Le Baule. “La guerra era cominciata, le divisioni corazzate tedesche correvano nelle pianure di Polonia; dalla mia casa sulla riva dell’Atlantico vedevo a decine ogni giorno arrivare i trasporti inglesi, che scaricavano il primo esercito britannico nel porto di Saint-Nazaire. Partivano i soldati francesi, con le modeste divise, coi pantaloni di fustagno e i visi annoiati dei pacifisti votati alla sconfitta; arrivavano gli inglesi, un esercito seicentesco, da una rinata merry England, ubriachi e spavaldi inaspettati guerrieri, terrore delle donne cattoliche di Bretagna, allegramente sicuri di una lontanissima vittoria”.
E ancora: “Tutti i dati di una civiltà parevano dissolversi in nebbia; ci stava innanzi un futuro incerto, per i destini del mondo e per il destino particolare di ciascuno. Tutte le vecchie ideologie parevano crollare, esaurite in una vana difesa e in una critica vana. Un vento di morte e di oscura religione sconvolgeva gli antichi stati d’Europa […] Il passato si allontanava come in un’altra vita, di là del fossato della guerra. La vita normale, la continuità delle generazioni e degli istituti era finita”.
Passeggiando lungo la spiaggia, il futuro autore di “Cristo si è fermato ad Eboli” cerca di capire quel che sta avvenendo. “Fu allora che la crisi che aduggiava la vita d’Europa da decenni, e che si era manifestata in tutte le scissioni, i problemi, le difficoltà, le crudeltà, gli eroismi e la noia del nostro tempo, scoppiò verso la sua soluzione in catastrofe”.
Lo Stato-idolo, divinizzazione storica scaturita come antidoto dell’angoscia primigenia, in una perenne e deformata ricerca del sacro, esigeva i suoi sacrifici di sangue. “Ogni guerra è un duello di dèi, un giudizio di Dio, nei due sensi del giudizio: che il Dio è giudice e giudicato. È giudicato esistente e vero soltanto il dio vincitore: la vittoria è la prova della sua nascita e della sua potenza, e della sua sacra legittimità. Gli stermini dei prigionieri e dei vinti sono non solo legittimi, ma necessari alle guerre religiose- ed è vano e stolto stupirsi dei bombardamenti delle città e della morte dei fanciulli quando si combatte per un idolo. Quei prigionieri, quei vinti, quelle donne, quei fanciulli non sono protetti da dèi, non hanno idoli potenti e vivi; non appartengono perciò al mondo dei riti, sono degli estranei, dei vinti, e devono perciò essere incatenati, resi schiavi, e immolati come vittime: victi e victimae”.
Levi è uno scrittore ed un pittore e le meditazioni davanti al mare assumono una suggestiva potenza immaginifica. Le mette su carta, in una sorta di allucinato e profetico poema filosofico. Compila i primi otto capitoli ma poi deve interrompere il lavoro e tornare a Parigi, da cui fugge prima che i tedeschi innalzino la propria bandiera sulla Torre Eiffel “in quel 14 giugno che potrebbe restare come data simbolica della fine di un mondo di civiltà, di arte e di cultura, che non ritornerà”. Il libro, al quale non volle mai rimettere mano, venne pubblicato una prima volta nel 1946, suscitando critiche e perplessità. Fu accusato, soprattutto a sinistra, come ricorda Giorgio Agamben (Neri Pozza, 2020) di essere condizionato da “una visione mistica e decadente”. Eppure, proprio oggi, nel fosco presente, offre una suggestiva interpretazione dell’irrazionalismo trionfante.
La tesi di fondo è che libertà appare impensabile, se ne ha orrore, affrontarla significa fare di continuo i conti con se stessi. Non c’è posto per la molteplicità e il pensiero, ma soltanto per l’unicità dell’azione. Credere, obbedire, combattere (la versione attuale è Dio, Patria e Famiglia…). “Mille nuovi Orioni percorrono cacciando, maligni e sorridenti, la gran selva del cielo. Al rombo dei loro corni si risvegliano i vecchi draghi, il sangue, pronto a essere versato, batte violento in tutti i cuori, pieni degli antichissimi terrori e delle antichissime speranze”.
La singola identità viene negata, la condizione umana affoga in un collettivo rito di rimozione. “Massa non è il popolo, e neanche la sua parte più bassa, la plebe, né è una determinata classe sociale, ma è la folla indeterminata, che cerca, con l’angoscia del muto, di esprimersi e di esistere […] Essa crea lo Stato-idolo, e lo Stato-idolo a sua volta riporta l’umanità alla condizione originaria di massa”.
Dirà poi lo stesso Carlo Levi: “La paura della libertà è il sentimento che ha generato il fascismo. Per chi ha l’animo di un servo, la sola pace, la sola felicità è nell’avere un padrone e nulla è più faticoso e veramente spaventoso dell’esercizio della libertà”.
Parole da scolpire.
Marco Cianca