Raffaele Cataldi ha lavorato come operaio all’Ilva di Taranto per ventun anni, dal 1997 al 2018. Operaio all’Ilva e nondell’Ilva perché non è mai stato una proprietà dei padroni, lui che come altri non ha mai accettato il ricatto occupazionale del complesso industriale più grande, importante, e allo stesso tempo mortale d’Europa. Ilva non significa solo acciaio, ma anche malattia, incidenti, soprusi; la sua storia è quella di una politica asservita agli interessi terzi malcelati dietro la promessa di più progresso, più sviluppo, più lavoro, più benessere per tutti, in un’eterna rincorsa a essere grandi tra i grandi a patto che il costo lo paghi qualcun altro: i lavoratori, i cittadini di Taranto, le generazioni passate, presenti ma anche quelle a venire. E se la letteratura d’inchiesta e scientifica è ampia, pur sempre distaccata, mancava il racconto dall’interno, che testimoniasse il cattivo sangue che scorre nelle viscere del polo siderurgico, ma anche di chi il cattivo sangue se lo procura per frustrazione e malattia. Mancava, infatti, la testimonianza diretta di chi in quei budelli angusti ci si è aggirato per anni, chi ogni giorno invece di indossare la tutta da lavoro ha indossato “la mimetica per combattere una guerra sul posto di lavoro. Guerra che posso raccontare in prima persona”, scrive Raffaele Cataldi nel suo memoir Malesangue (Alegre, 144 pagine, 13,00€), in cui la vita privata è impossibile scindere da quella pubblica, il conflitto interiore si alimenta di esteriore, il senso di solitudine si scontra contro la rabbia.
Il libro esce nel gennaio 2025, praticamente a un anno di distanza dal commissariamento della fabbrica – avvenuto per decreto a febbraio 2024, per la cui gestione Arcelor-Mittal è finita sul banco degli imputati con gravissime accuse (tra cui associazione a delinquere, truffa allo Stato, inquinamento e disastro ambientale) – e ripercorre a ritroso una vicenda lunga dodici anni. Tutto ha inizio il 26 luglio 2012, quando la giudice Patrizia Todisco, nell’ambito dell’indagine denominata “Ambiente Svenduto”, firma il sequestro degli impianti dell’area a caldo dell’Ilva per i reati di disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro. La mobilitazione sindacale è immediata, con la convocazione per il 2 agosto da parte degli allora segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Savino Pezzotta e Luigi Angeletti, di una manifestazione a Taranto contro la chiusura della fabbrica e per cercare una soluzione che coniugasse l’occupazione con l’ambiente. Bloccate la città, è stato l’imperativo imposto agli operai terrorizzati all’idea di perdere il posto di lavoro – «Dove dobbiamo andare a mangiare se la fabbrica chiude?» -, ma non un cenno alla salute di cittadini e lavoratori, allo sfruttamento imperterrito di quel territorio già martoriato dall’industria pesante dell’Eni, della Cementir, dell’Arsenale Marittimo. L’obiettivo è difendere i livelli occupazionali, non la qualità del lavoro e dei cittadini. Dalla rabbia per questa imperdonabile omissione da parte dei sindacati nasce un’altra storia, quella degli operai del Comitato dei Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti che ribaltarono il niet dei confederali e della categorie a prendere la parola durante la manifestazione sfondando il muro di omertà con la forza di un’Apecar, uno striscione e una cassa con microfono. «Spezzare le catene del ricatto occupazionale» contro una deliberata strage di Stato, riuscire a portare la cittadinanza nello stabilimento, guardare in dritto degli occhi chi e cosa ha compromesso l’esistenza di tante vite spezzate prematuramente. «Nella busta paga devono mettere anche la voce tumori», si sentiva urlare nella piazza. E tuttavia, pochi giorni dopo, il 3 dicembre 2012, il primo decreto Salva Ilva autorizza la prosecuzione della produzione. In questi dodici anni, scrive Cataldi, tra i fondatori del Comitato, «né il Governo né i sindacati hanno lavorato […] con la diligenza, la serietà e la determinazione che vertenza Ilva richiedeva. La sicurezza sul lavoro in fabbrica non è cambiata, anzi risulta peggiorata, considerato lo stato di abbandono degli impianti privi di manutenzione. Di conseguenza è aumentato anche il numero di incidenti mortali negli ultimi anni». Dal 2012 al 2020, infatti, sono stati registrati nove decessi sul posto di lavoro «per colpa di quel tanto agognato pane da dover portare a qualunque costo a casa»; queste “morti bianche”, incalza, «sono numeri che i padroni mettono in preventivo nei loro bilanci annuali […] per l’azienda non si calcola il valore dell’essere umano in quanto tale, ma gli si attribuisce un valore economico, lo si considera un costo di produzione, fosse addirittura un fastidio necessario […] Tutto nel nostro paese di muove attorno ai soldi: nella lunga, complessa, intricata vicenda Ilva c’è chi è arrivato addirittura a giustificare le morti in azienda in funzione del PIL […] Tutto viene giustificato: dagli incidenti sul lavoro alle malattie, fino alle morti in fabbrica. Sono morti che non fanno rumore».
E pure tutto ciò non ha impedito che la lotta si arrestasse. Contro, innanzitutto, sindacati sempre più “filopadronali” che eliminavano componenti scomodi a un’azione gestita fino a quel momento in maniera incontrastata. Per le scelte compiute, per gli accordi al ribasso, «era evidente che il sindacato tendeva a non essere più il punto di riferimento ma, al contrario, puntava ad arginare e a emarginare gli operai ritenuti più scomodi […] Abbandonati dai sindacati e odiati dai padroni, per anni siamo finiti per diventare esuli dentro la fabbrica». Una delusione, comunque, e cocente, dalla quale però i lavoratori hanno capito che i diritti bisogna difenderseli da soli, «senza delegare a nessuno». E “Io non delego, io partecipo” è stato sin da subito lo slogan distintivo del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti: «Il concetto di non delegare – scrive Virginia Rondinelli, attivista del Comitato, nella prefazione – per noi ha rappresentato l’avvio del processo di partecipazione da cui la nostra comunità sembrava esclusa per una sorta di assuefazione a un destino assegnato e non modificabile, perché i meccanismi di pacificazione messi in atto dal sistema sono efficaci e noi non siamo un’eccezione». Quel destino a cui, racconta Cataldi, ti abituano sin dall’infanzia, quando già a scuola ti insegnano i cicli di produzione dell’acciaio: non nasci a Taranto, nasci all’Ilva, madre e matrigna. Ma in questo sforzo collettivo di incidere nei processi decisionali, sottolinea Rondinelli, «il concetto di politica dal basso prendeva forma e ci rendeva la forza necessaria per contrastare le decisioni calate dall’alto. Avevamo ritrovato un terreno comune di confronto e di progettualità, partendo dal vissuto personale». Perché, aggiunge Simona, altra attivista del Comitato, «quando ti accorgi che non puoi cambiare le cose dal di dentro – perché hai a che fare con tanti gattopardi pronti a cambiare tutto perché nulla cambi davvero – l’unica cosa sensata è uscire per non diventare complici di un sistema che a parole dice di volerti difendere da ricatti e soprusi ma nella pratica quotidiana fa accordi al ribasso».
Tra i tanti aneddoti contenuti nel racconto di Raffaele Cataldi, uno in particolare lascia quantomeno attoniti. Dopo aver acquistato la fabbrica nel 1995, aggirandosi in macchina per Taranto Emilio Riva notò un gran numero di uomini con indosso la tuta dell’Ilva. Sorpreso, o ironico, disse al suo autista: «Non sapevo he nell’accordo con cui ho acquistato l’Italsider fosse compresa tutta la città vecchia». Cataldi spiega che all’epoca le tute si portavano a lavare a casa e capitava che, una volta dismesse, venissero regalate ad amici e conoscenti che facevano i pescatori, i meccanici, i muratori, i falegnami, gli ambulanti. «Non aveva torto Riva a pensare che nell’accordo dell’acquisto della fabbrica ci fosse inserita la città intera. Tutta Taranto aveva quelle tute. E tutte le tute erano del padrone. Chi aveva le mani sulla fabbrica, aveva le mani sulla città». Mani delle quali, passo dopo passo, il Comitato sta provando ad allentare la presa facendo rete con gli altri attivisti del Paese che lottano sul campo – No Tav, No Tap, No Triv, No Grandi Navi, No al Carbone, No Tempa Rossa, No Muos – ribadendo la centralità della società civile anche attraverso il coinvolgimento di numerosi profili pubblici che sostengono la lotta: Michele Riondino, attore e regista tarantino che ha portato sugli schermi il pluripremiato film Palazzina Laf, ambientato proprio nello stabilimento Ilva; i cantanti Roy Paci e Antonio Diodato che collaborano attivamente alla realizzazione del festival musicale autofinanziato dell’Uno Maggio Libero e Pensante maggio – in cui, spiega Cataldi, non c’è nulla da festeggiare, ma per il Comitato è il megafono di tutti i territori in lotta in Italia e all’estero con l’obiettivo di far conoscere a un pubblico sempre più ampio le vertenze dei territori italiani che non trovano voce nei media mainstream -, la giornalista d’inchiesta Valentina Petrini, tarantina, che ha scritto una coinvolgente inchiesta dal titolo Il cielo oltre le polveri (qui la nostra recensione).
Quello di Cataldi è un libro sospinto dall’urgenza di raccontare innanzitutto l’uomo oltre la tuta da lavoro – con le sue fragilità e paure, le sue speranze e la forza di realizzarle. Complice la tendenza di una certa narrazione che semplifica fino a depauperare, negli anni la storia del complesso siderurgico è stata privata della sua imprescindibile componente umana: operai ridotti a numeri; incidenti e vittime concretizzati in sterili percentuali; sviluppo economico e sociale sintetizzati in astrusi indicatori. Ma la sofferenza, le lacrime, la rabbia e la lotta vivono e agiscono sulla e attraverso la carne. Ed è per questo che Malesangue è un racconto necessario.
Elettra Raffaela Melucci
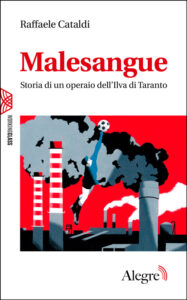
Titolo: Malesangue. Storia di un operaio dell’Ilva di Taranto
Autore: Raffaele Castaldi
Editore: Alegre – Collana Working class
Anno di pubblicazione: 2025
Pagine: 144 pp.
ISBN: 9791255600367
Prezzo: 13,00€






















