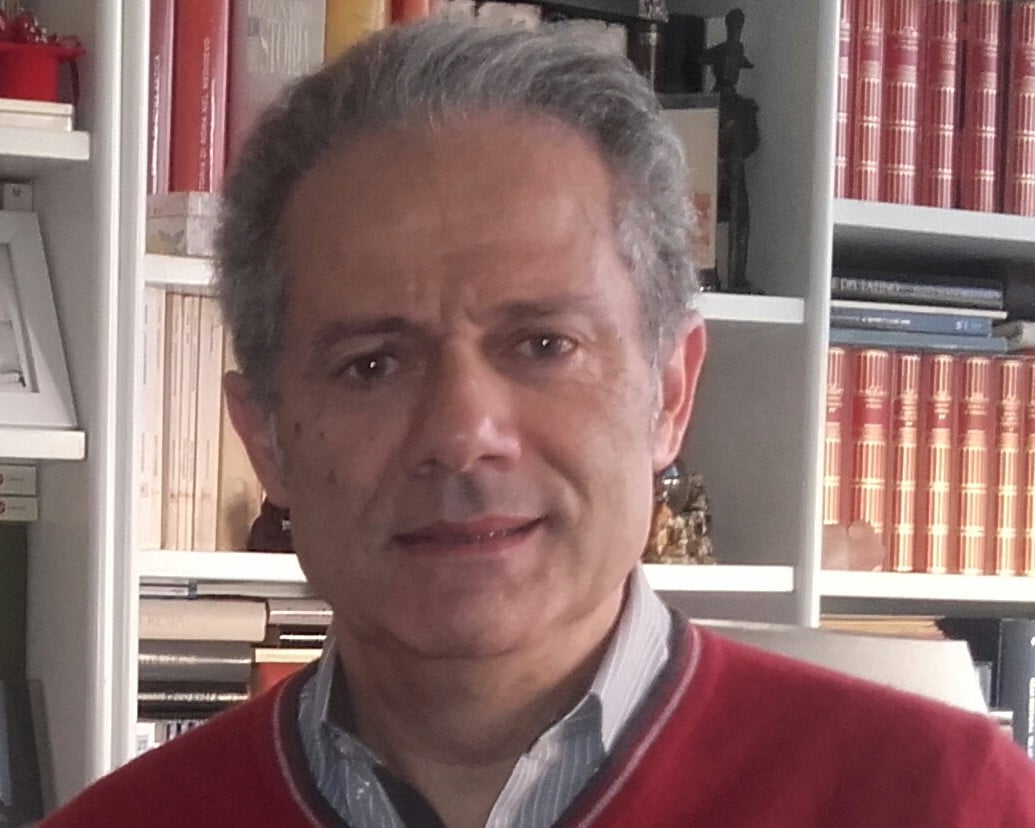Due importanti iniziative scientifiche, un seminario italo-francese, organizzato dall’Associazione Lavoro e Welfare presso la Camera dei Deputati e un Convegno a Roma della Rivista giuridica del lavoro, sull’attuazione degli artt. 39 e 46 della Costituzione, possono contribuire a riporre all’attenzione dello studioso (e sarebbe auspicabile anche del legislatore), il tema della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa.
È questo un profilo delle nostre relazioni industriali che non ha trovato adeguato sviluppo, sia dal punto di vista dell’iniziativa legislativa, che quello dell’autonomia collettiva e, probabilmente, anche nell’approfondimento della dottrina giuslavorista.
Eppure nell’art. 46 della Costituzione, concepita dai Padri costituenti come una norma cardine del nostro modello di democrazia industriale, il diritto a collaborare alla gestione delle aziende è riconosciuto, al pari del conflitto collettivo e lo sciopero, come strumento di elevazione economica e sociale dei lavoratori.
L’inquadramento sistematico delle diverse teorie della partecipazione si è sviluppato nella distinzione nei modelli c.d. “antagonistici”, o “collaborativi”, o “integrativi” (Guido Baglioni, Mimmo Carrieri); o quelli relativi alla partecipazione “alle decisioni” e/o “all’economia”, secondo la ricostruzione di Massimo D’Antona, che voleva indicare, nel primo caso la partecipazione dei lavoratori proprio al processo delle decisioni d’impresa, o alle modalità di distribuzione della ricchezza dell’impresa (la partecipazione ai successi economici della gestione).
Il concetto stesso di partecipazione configura, certo, qualcosa di diverso rispetto al modello classico delle relazioni industriali informato, sostanzialmente, sul conflitto (latente o palese). Ciò può già spiegare il vizio culturale di fondo del sindacato che ne ha reso difficile lo sviluppo: la tradizionale predilezione del conflitto, per il raggiungimento di intese contrattuali, come prospettiva meno compromettente rispetto a quella della partecipazione.
Né, d’altro canto, aperture verso partecipazione o cogestione sono pervenute dal fronte imprenditoriale, tradizionalmente plasmato su una logica gerarchica ed autarchica della attività di direzione aziendale. Unica eccezione nell’esperienza del nostro Paese, il modello sviluppato, negli anni ’60, da quell’illuminato imprenditore di Ivrea che era Adriano Olivetti, con il “consiglio di gestione”, che vedeva al suo interno una componente di lavoratori ed era approvato con referendum.
Dopo l’autunno caldo e con l’emanazione dello Statuto dei lavoratori, il dibattito sul tema rimase, di fatto, condizionato dall’equazione “partecipazione vs. democrazia sindacale”, pur non escludendosi, astrattamente, la prospettiva di una legislazione di sostegno nei confronti del sindacato, che non escludesse ipotesi di partecipazione operaia agli organismi societari.
E infatti, Gino Giugni aveva cercato di sostenere come l’idea della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa non fosse poi così lontana da quella logica che permeava lo Statuto dei lavoratori, nel senso di un rafforzamento della presenza sindacale nei luoghi di lavoro. Da questo punto di vista lo Statuto, secondo il suo riconosciuto padre, non avrebbe impedito, anzi avrebbe potuto favorire ulteriori interventi legislativi rivolti a sviluppare un modello partecipativo dei lavoratori. Una prospettiva, questa, rivolta a ridimensionare la diffusa concezione che la democrazia industriale nel nostro Paese si potesse sviluppare solo in termini di “partecipazione conflittuale” dei lavoratori.
In un noto dibattito ospitato dalla rivista Quaderni Mondoperaio nella metà degli anni ’70, che coinvolse tra i più illustri studiosi di relazioni industriali, Giugni sosterrà fino in fondo tale impostazione ponendosi anche in contrasto con le posizioni aprioristicamente di chiusura di autorevoli leaders sindacali del tempo.
La proposta di Giugni era orientata verso un modello che vedesse la partecipazione del sindacato alle politiche di definizione delle procedure di programmazione economica, con la possibilità di esercitare, successivamente, un controllo di gestione sul rispetto di tali programmi.
Quali prospettive, dunque, per la partecipazione dei lavoratori, a fronte di una mancanza di iniziativa legislativa pone in essere un vero e proprio gap partecipativo del nostro Paese rispetto alle altre esperienze europee? Ci si riferisce non solamente al modello tedesco, di certo la massima espressione del tema (dalla Repubblica di Weimar, alla regolamentazione normativa dei primi anni ’50 fino alle regole attuali), ma anche alle esperienze di partecipazione, ormai consolidate, in Svezia, Danimarca, Paesi Bassi. Recentemente, in Francia la legge 504/14 giugno 2013 ha trasferito anche nel settore privato il meccanismo partecipativo nei c.d.a., attraverso la designazione sindacale del comité d’entreprise, potenziando, altresì, l’informazione e la consultazione dei lavoratori.
Probabilmente, un’occasione mancata è stata la riforma del nostro diritto societario (D.lgs. n.6 del 2003), che nella materia riguardante i sistemi di governance delle società, di fatto, non si occupò di possibili sistemi di rappresentanza dei lavoratori.
In Parlamento giacciono, attualmente, vari progetti di legge e non vi è dubbio che lo sviluppo di una prospettiva legislativa in materia di partecipazione dei lavoratori, si rivelerebbe oggi ancora più opportuna, in un mercato caratterizzato da maggiore flessibilità e nuove concezioni di sicurezza del lavoro. Essa potrebbe configurare, infatti, un impegno assunto dalle parti verso progetti di innovazione organizzativa che migliorino produttività delle imprese, oltre che qualità e sicurezza del lavoro.
L’iniziativa, indubbiamente, va rimessa, in prima battuta, al legislatore, in attuazione della riserva di legge contenuta nell’art.46 della Costituzione.
In questa materia, sì, che il legislatore dovrebbe prendere l’iniziativa, autonomamente e anche indipendentemente dalla volontà delle parti sociali, pur se dalle maggiori confederazioni sindacali sembrano provenire segnali favorevoli verso forme di partecipazione economica (azionariato dei lavoratori) e di legislazione di sostegno a tal fine. Ciò nella maturata consapevolezza che la presenza di rappresentanti dei lavoratori nei c.d.a., oltre ad offrire maggiori garanzie sulle scelte d’impresa, può anche essere funzionale alla ricostruzione di un’idea di comunità aziendale (Cesare Damiano).
Il legislatore, dunque, dovrebbe intervenire e imporre nei c.d.a., come è avvenuto in Francia, una percentuale minima di amministratori rappresentanti i lavoratori. Rappresentanti di lavoratori che dovrebbero essere cosa diversa dalle RSA o RSU, che rimangono organismi di contrattazione.
In assenza di un intervento del legislatore può avere un ruolo “costitutivo” l’autonomia collettiva (tenendo conto anche delle attuali luci ed ombre sulla contrattazione collettiva e della crisi della rappresentanza)?
In altre parole la riserva di legge prevista nell’art.46 della Costituzione può essere intesa non in senso assoluto, ma relativo, come è avvenuto per la norma sullo sciopero (art.40) e far si che la materia possa essere regolata, non direttamente da norme di legge, ma da regole provenienti dall’ordinamento intersindacale?
Probabilmente si, facendo appello al “buonsenso pragmatico” invocato da Mimmo Carrieri e rendendo, a tal fine, la contrattazione, meno aspra e conflittuale sui luoghi di lavoro, per poter poi ritrovare forme di coinvolgimento diretto dei lavoratori nella gestione dell’azienda.
È una prospettiva di cooperazione capitale-lavoro che, non solo potrebbe avere effetti favorevoli sull’occupazione, ma offrirebbe un’immagine di Europa più sociale e meno liberale.