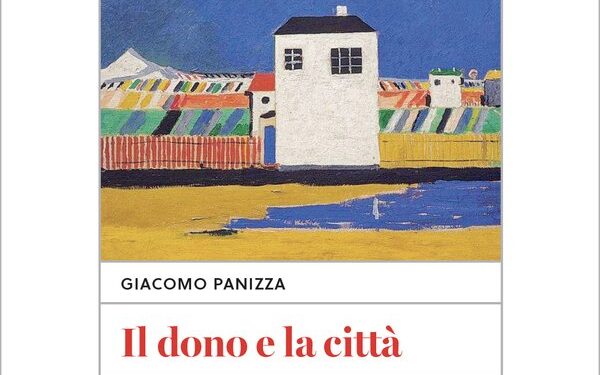Povertà e disagio sociale sono in aumento e sarebbe ridondante ripercorrere i dati alla ricerca di una spiegazione pressoché lapalissiana. Queste evidenze sono specchio di un malfunzionamento strutturale della politica e piuttosto che di agire sul fenomeno, le governance si avvalgono del fenomeno come pratica di circonvenzione di una minoranza ai fini del consenso. Ma il problema – anzi, i problemi, permangono e si acuiscono sempre più. E provando a mettere cerotti su una ferita ben più profonda con interventi deboli e mai strutturali, la politica tra l’altro contravviene alla sacra Carta costituzionale: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», recita l’articolo 2. Dove alberga il dovere di solidarietà negli indirizzi dei governi? Nella deroga della questione al terzo settore? E posto sia giusto, di quale legittimità gode un apparato solo di recente normato? Vissuto più come stampella che come pilastro insieme a Stato e Mercato, il terzo settore del volontariato è una sorta di zona franca in cui vengono riversati i problemi del sociale, della gente in difficoltà, sempre più povera e disperata, ammalata fisicamente e psicologicamente, senza prospettiva; una mole di problematiche scaricata interamente sulle spalle di privati cittadini che si prodigano a farsi carico del prossimo. È in questo senso che ragionare sul volontariato significa ragionare sull’identità dello Stato e, si aggiunge, sul suo corretto funzionamento. Ma non solo: investito di un ruolo sempre più cruciale, il volontariato stesso deve riflettere sul proprio funzionamento e sulla propria salute, sui propri indirizzi che corrono il rischio di derivare in debolezze e spirali autoriferite, sull’urgenza di un intervento che non sia solo sugli effetti o i sintomi ma che si traduce in capacità di indagine e azione sulle cause.
Ne Il dono e la città (Bibliotheka, 152 pagine, 18,00€) Don Giacomo Panizza riflette su questo e molto altro per tratteggiare il futuro del volontariato e lo fa a partire dalla messa in discussione del concetto più abusato e travisato: la democrazia, che «democraticamente […] si è sviluppata nel modo peggiore, riducendo democraticamente, anno dopo anno, i fondi riguardanti i bisogni e i diritti alla minoranza degli italiani ammalati e disagiati». È qui che si inverano le contraddizioni più profonde di una società di per sé nata con i più nobili propositi di uguaglianza, a cui il sistema del terzo settore ha intenso contribuire non senza discrasie interne. «I diritti delle persone non vanno sottoposti al buon cuore di alcuni volenterosi, ma a un welfare efficace governato da istituzioni dedite al progresso umano e sociale dell’intera popolazione. Nessuno escluso». lI fine era e resta «mixare il welfare e il volontariato solidale, complementari a patto che funzionino bene entrambi». Don Giacomo Panizza lo sa bene, perché in prima persona ha contribuito alla nascita del Terzo settore con una capillare opera sul territorio,: bresciano di nascita, nel 1976 ha fondato a Lamezia Terme “Progetto Sud”, una comunità autogestita insieme a persone con disabilità, lottando contro la ndrangheta, mischiandosi agli ultimi sempre alzando la voce contro chi questi ultimi li ignora relegandoli ai margini della società. Ed è proprio la sua azione diretta al e sul territorio, con e per gli ultimi, che lo ha condotto a una lunga riflessione, confluita in queste pagine, sul valore, il senso profondo e il significato di concetti e parole come solidarietà, coesione sociale, dono, gratuità. Scrive Panizza: «La solidarietà va ben oltre lo spontaneistico moto di bontà d’animo che si traduce in gesti benefici occasionali; solidarietà è riconoscersi e muoversi in un “insieme” […] nel quale ciascun singolo svolge la propria parte guardando al tutto, altrimenti si tratta di un’altra cosa, che possiamo chiamare beneficenza, elemosina, bontà, altruismo, obolo, carità a tu per tu. La solidarietà, piuttosto, è una pratica di convivenza umana e di convenienza individuale e collettiva, che chiede a ciascuno e a tuti la responsabilità di sostenere ciascuno e tutti». Non mancando, poi, di criticare proprio chi è all’interno dell’arcipelago del volontariato e ne polverizza le azioni attraverso inutili personalismi e leaderismi fini a sé stessi, senza mancare di “processare” anche il Codice del terzo settore: «È essenziale […] fare coesione con le molteplici componenti della società a impegnarsi […] a “lasciare il mondo un po’ meglio di come l’abbiamo trovato”. Il Codice del terzo settore azzoppa il volontariato. Al più, incrementa le singole “buone azioni”, riduce i significati di concetti come solidarietà, sussidiarietà e bene comune, cancella visioni di politiche sociali generatrici di uguaglianza nel Paese e nel mondo. Sarebbe un grave errore esaurirsi in simili astoriche “visioni”».
È corrente un certo tipo di volontariato che «mette le pezze ai danni», che è cieco davanti alla secondo strato della realtà. Piuttosto c’è bisogno di volontari attenti che si spingano oltre, che si facciano attori coscienziosi e meno operatori di interventi isolati. «Le sole buone azioni e le beneficenze occasionali offuscano i diritti dei poveri nel mentre si accresce un “liberismo feroce” incapace di riconoscere l’alterità e la grandezza delle persone, di ciascuna persona. I movimenti di volontariato esistenti nella forma di minoranza attiva sono contrari a una gratuità che loda chi aiuta e passivizza chi viene aiutato. L’azione volontaria necessita di un vaglio qualitativo sulle intenzioni, sul processo di aiuto e sui risultati raggiunti, il tutto nel verso della promozione umana e non dell’assistenzialismo».
Ma anche eludere la trappola di somigliare sempre più ai servizi gestiti dal privato for profit, che mettono in campoprestazioni lontane da promozione e inclusione sociale. «È necessario che il terzo settore ritorni a voler imprimere a sé stesso un indirizzo culturale e politico, decidendosi a svolgere un servizio “pubblico” capace di superare la trappola del mero mercato dei servizi sociali e puntando a collaborare con tutte quelle forze sociali e istituzionali che mirano alla costruzione di welfare comunitari». In questo senso anche la formazione è importante e Panizza avverte dell’urgenza di «scuole interne, i mano a raggruppamenti del terzo settore e non alle fondazioni di ditte o banche, per poter foggiare anche idee e pensieri sociali maturati e appresi dalle proprie esperienze dirette. Permane eclatante il problema della dignità di coloro che sono impegnati nel lavoro sociale, quasi ovunque senza possibilità di carriere, non sempre con dignità di statuto di lavoratori, abituati a contratti flessibili e precari».
E allora in mano a chi sta il rilancio del sociale? Al sociale stesso: «Potrà rilanciarsi se studia, ricerca, sperimenta, si appassiona e appassiona, se si dota di strumenti e linguaggi, se comunica significati, se intreccia e ascolta e valorizza le diversità sempre più manifeste. Se è convinto. E se convince. Il terzo settore si prende cura dello stato sociale. Il terzo settore e le sue grandi reti organizzate […] hanno buone ragioni per rilanciare i temi sociali dall’interno di uno Stato sociale… e di un’Europa sociale».
Aprire vie di liberazione, «liberare i bisognosi dal bisogno, includere gli esclusi, socializzare gli inclusi»: è questa la finalità e l’etica del volontariato: «Implica che ogni realtà organizzata sappia avere la padronanza di visioni politiche e di divulgarle, anche se “non necessariamente ogni volontario o volontaria deve saper essere capace di proposta come di denuncia verso le Istituzioni, i vari poteri e la società».
Elettra Raffaela Melucci
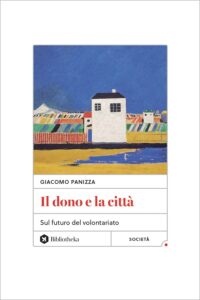
Titolo: Il dono e la città. Sul futuro del volontariato
Autore: Giacomo Panizza
Editore: Bibliotheka – Collana Reti
Anno di pubblicazione: 2024
Pagine: 152 pp.
ISBN: 9788869349034
Prezzo: 18,00€