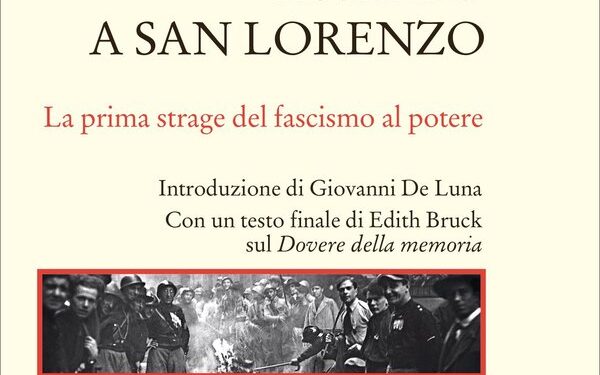All’esercizio della memoria siamo invitati a più riprese. Un invito, però, che spesso viene declinato o trascurato, oppure reso oggetto di polemiche divisive, o peggio cancellato dalle nostre agende. Dal «secolo della violenza» che è stato il Novecento non abbiamo imparato alcunché. Puntuale e impersonale, ogni anno viene messa in scena la farsa istituzionale che resuscita i morti dei luttuosi eventi che hanno segnato la nostra Storia contemporanea, ma poi quegli stessi morti vengono prontamente rimessi a dormire in attesa che la retorica torni a evocarli l’anno successivo. Proprio tra qualche giorno ricorrerà il settantanovesimo anniversario della liberazione d’Italia dal nazi-fascismo e già ci si frega le mani (o ci si profonde in sbadigli) all’idea di falchi e colombe che volano in circolo sul cadavere della memoria. La verità è che nessuno, da qualche tempo a questa parte, sa davvero cosa farsene della memoria: è stata ridotta a spettacolo di ombre che si muovono incerte sullo sfondo di un contemporaneo che eccede i suoi confini; proviamo ad agguantarne uno scampolo perché “è doveroso”, ma la distanza che stiamo mettendo tra il “qui e ora” e il “lì e allora” è sempre più incolmabile. In mezzo sta l’entropia del nostro egotismo e il passo successivo, quindi, sembra la cancellazione definitiva della memoria, l’abiura di un passato che sempre più fatichiamo a riconoscere e a cui vorremmo profondamente non appartenere. Non siamo il prodotto di un processo di sintesi della memoria, ma di rigurgito. In qualche modo ci siamo espulsi dalla Storia. E allora occorre tornare ad appropriarsene, sia della Storia che della sua memoria, a maggior ragione se tutto quanto ci circonda è un appello alla consapevolezza di chi eravamo e di potremmo tornare a essere. E se quel Novecento della violenza è stato come un vento di tempesta che distrugge e contemporaneamente disperde semi pronti a rinascere gramigna o papaveri, rieccoci, a distanza di tempo, a veder sbocciare quei germogli e a fare la conta di chi è gramigna e di chi è papavero. Risvegliamoci da questa amnesia collettiva e sforziamoci di andare oltre la paginetta di sussidiario.
Il nuovo libro di Gabriele Polo, giornalista, saggista ed ex direttore del quotidiano il Manifesto, corre esattamente su questi binari: Assalto a San Lorenzo. La prima strage dei fascisti al potere (Donzelli editore, 112 pagine, 16 euro) è la sceneggiatura di un terribile episodio che ha letteralmente marchiato a sangue l’inizio del ventennio più buio del Novecento e che pure in pochi, pochissimi, conoscono. Non perché mimetizzato nel convulso fraseggio della Storia, ma perché se ne è operata una scientifica rimozione, da parte delle vittime così come dei carnefici. «Un pezzo dimenticato del nostro passato, che vale la pena indagare per assegnargli finalmente uno spazio nella memoria del paese». Ridando dignità alla memoria del fatto storico, due concetti in perenne e fragile rapporto dialettico, Polo ricostruisce la genesi e la cronaca del 30 ottobre 1922, giorno in cui le colonne di camicie nere mussoliniane si apprestano a prendere definitivamente Roma in una spirale di violenza che nessuno, fino in fondo, immaginava essere solo all’inizio. Una violenza che il fascismo rese «la sua arma politica più efficace», come acutamente sottolineato dallo storico Giovanni De Luna nella prefazione. Ma oltre a essere la data in cui si ufficializzava la consegna del Paese in mano a Mussolini, il 30 ottobre 1922 è anche il giorno dello scioglimento di un irrisolto che si traduce in vendetta: prendere San Lorenzo, il quartiere rosso a est di Roma , il “fortino cintato” dalle Mura Aureliane compreso tra il cimitero del Verano e Porta Tiburtina e attraversato dal tratto iniziale di via Tiburtina. Un confine fisico, ma anche sociale: «muratori, artigiani, ferrovieri, tranvieri, netturbini e la varia umanità di immigrati dal Centro-sud del giovane Regno d’Italia, che vive di espedienti, traffici, piccoli furti» e che animava e difendeva quel quartiere oggetto di ripetuti tentativi di espugnazione da parte degli squadristi, tutti andati a vuoto. Quel giorno, però, mentre Mussolini si apprestata a consegnare al re la lista dei ministri, l’ossessione si sarebbe compiuta: un pretestuoso scontro a fuoco avviato dai fascisti in marcia verso il centro cittadino e sostenuto dall’esercito regio per vendicare l’umiliazione di essere stati puntualmente respinti da quella comunità di eversivi comunisti, socialisti, ma anche repubblicani o semplici cittadini. Gli abitanti del quartiere si difendono come possono dalla rappresaglia, sparando a loro volta o lanciando laterizi dai tetti, ma il fuoco nemico lascerà sul terreno un numero imprecisato di vittime civili che, su ordine del generale Pugliese, verranno trasportate poche ore dopo al cimitero del Verano per essere tumulati «senza cerimonia funebre, per evitare nuovi disordini». Insieme ai corpi, in questo modo, verrà seppellita anche la Storia e la memoria dell’avvenimento: la cancellazione giuridica avviene tramite una sentenza del tribunale del 9 luglio 1923 «per insufficienza di prove per i delitti sopra specificati, essendone rimasti ignoti gli autori», quella della memoria per un’opera di rimozione che «diventa condizione indispensabile per la sopravvivenza». Gli sconfitti rossi non possono ricordare perché è cocente il rammarico per la divisione dei partiti antifascisti che, all’alba di un momento decisivo, non seppero trovare la mediazione per evitare la strage. Il quartiere cambia identità e il senso di comunità che lo contraddistingueva è sradicato: «In anni di laceranti conflitti, l’identità territoriale prevale spesso sulle divisioni politiche o culturali. Lo stesso vale anche per i leader politici, che il quartiere tiene insieme nonostante le differenze […] ognuno è solo di fronte ai problemi particolari del vivere quotidiano, ma è “costretto” ad affrontare insieme agli altri l’indifferenza o il rigetto che l’esterno dimostra nei suoi confronti».
Nessuno sa di preciso quante fossero le vittime, le poche ricostruzioni postume non forniscono mai lo stesso dato. Ma «che siano sette, otto, nove o tredici, i morti di San Lorenzo rimangono comunque dei semplici “numeri”, senza storia e senza possibilità di memoria. Senza riconoscimento pubblico, verità o ricordo […] Vittime minori e innominate, “figli di nessuno”. Ma proprio per questo esemplari – con la loro vicenda e al pari dei loro carnefici – di una storia con cui non si è voluto mai davvero fare i conti». A distanza di poco più di cento anni, Gabriele Polo tributa loro quel “dovere della memoria” (e si aggiunge anche “della Storia”) evocato nella postfazione da Edith Bruck: Vittorio Gezzi, 20 anni, operaio delle ferrovie; Gioacchino Secoli, 23 anni, manovale; Fausto Berretta, 25 anni, operaio; Alberico Pierini, 37 anni, meccanico; Maria Gagliardi, 38 anni, massaia; Sante Ascenzi, 40 anni, carrettiere; Teodoro Bielli, 48 anni, calzolaio; Alfonso Fanelli, 58 anni, stagnaio. La nona vittima, Umberto Pallocca, si aggiunge qualche giorno dopo sul registro del cimitero. Ognuno con le proprie storie, mestieri, vite. Una Spoon River di cui però non resta nemmeno una targa commemorativa «nel paese che con le lapidi assolve le responsabilità e anestetizza il dolore». Quello stesso Paese che in un cimitero monumentale, però, ospita un mausoleo dedicato ai “martiri fascisti” e che il 28 ottobre di ogni anno è teatro di commemorazioni, saluti romani e piccole marce cimiteriali. Da qualche parte, in quello stesso cimitero, le semplici lapidi dei morti di San Lorenzo sono poche e sbiadite, il tempo sta vincendo anche sulla muta pietra.
Con il suo meticoloso lavoro di ricerca tra archivi e territorio, Polo consacra la strage di San Lorenzo a episodio emblematico dell’era fascista e dei caratteri che la contraddissero – violenza, eversione, impunità, propaganda – attraverso una narrazione che non a caso si è definita sceneggiatura perché nell’attraversare questa ricostruzione sembra di assistere a un film: un linguaggio secco, incalzante, un magistrale equilibrio tra la cronaca giornalistica e drammaturgia immaginifica, scevro da aggettivi che non aggiungerebbero altro a una storia già terribile di suo. Come rilevato ancora da De Luna nella prefazione: «Ne emerge tutta intera la ricchezza di passioni e di motivazioni che animano la “spontaneità” popolare, ma anche il suo inevitabile consegnarsi alla sconfitta quando viene abbandonata a sé stessa dall’“organizzazione” (in quel caso i partiti antifascisti e i sindacati, annichiliti dalla sconfitta e incapaci di tentare la benché minima reazione per opporsi alla marea montante dello squadrismo)». Nessuna mitizzazione dei morti, nessun martire. Solo «uomini e donne in carne e ossa, disposti a morire in nome della libertà e della lotta contro i soprusi dei dominatori».
La forza di questo racconto non sta solo nella doverosissima operazione di rivivificazione di fatti e identità sconosciute, ma anche nel pregio di sollevare domande su chi eravamo e chi siamo. In nuce a questa vicenda si agitano responsabilità passate e presenti. E in questo senso, il lavoro di Gabriele Polo offre la possibilità di riaprire i conti con un passato che una certa parte di popolazione non riesce proprio a vedere per quello che è stato. «Resta un dato di fatto: la lotta di San Lorenzo, pur sconfitta, è oggi una speranza per tutti».
Elettra Raffaela Melucci
Titolo: Assalto a San Lorenzo. La prima strage dei fascisti al potere
Autore: Gabriele Polo
Editore: Donzelli – Collana Saggine
Anno di pubblicazione: 2024
Pagine: 112 pp.
ISBN: 978-88-5522-561-8
Prezzo: 16,00€