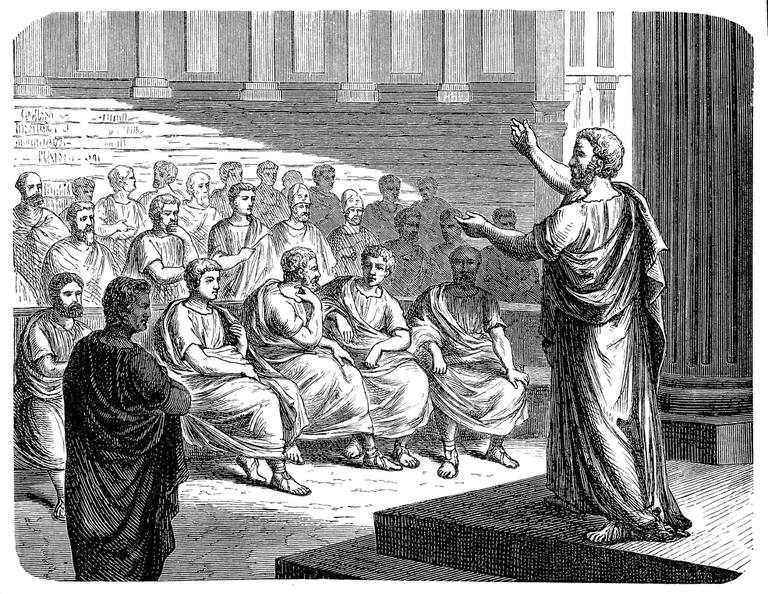Tony Blair, solitario vagabondo lungo la Terza Via, mette le mani avanti: “Ora ci minaccia il populismo di sinistra”. Moisés Naìm, scrittore ed economista, teorizza che la polarizzazione sia il peggior nemico della democrazia. L’ultimo numero della rivista Internazionale pone la domanda se Kamala Harris spingerà in avanti le posizioni progressiste o asseconderà l’ala conservatrice del partito democratico.
Il voto negli Stati Uniti ha riacceso il mai sopito dibattito sul moderatismo e la radicalità. Una discussione a livello mondiale di un tema che da noi ha ossessionato e ossessiona ancora: per vincere e governare è indispensabile sfondare al centro? Una visione geometrica della politica che individuava i ceti benpensanti come il fulcro sul quale poggiare la leva per sollevare sé stessi. Una teoria ambigua e foriera di compromessi, già discutibile quando la società era divisa in classi, e quelle di mezzo venivano dipinte come le uniche dispensatrici di un legittimo consenso.
Sottoproletariato, proletariato, piccola e media borghesia, possidenti. Categorie che non esistono più, travolte dalla massificazione, dal consumismo, dall’appiattimento degli stili di vita. E abbrutite dalla crisi finanziaria. Un unico blocco sociale cementato dal rancore e dalla rabbia. Che non si è sentito rappresentato, che ha preso di petto le fallimentari élite ed è corso sotto la bandiera della ripulsa, ubriacandosi con il vino dell’uomo forte. Ecco la morte annunciata dei principi liberali e l’ascesa delle democrature.
Ma questa è già storia vecchia, roba degli anni scorsi, che sembrano un secolo fa. Perché poi è arrivato il coronavirus. Ci sono un prima e un dopo, un ante e un post Covid, un nuovo computo del tempo nella storia dell’uomo. E allora che senso ha riproporre l’antinomia tra radicali e moderati nel primo anno, horribilis, della nuova era? L’ozioso e sterile cicaleccio che sta accompagnando l’elezione di Joe Biden può solo accrescere la confusione e aggravare la miopia. Che il nuovo presidente sia un grigio e attempato signore non può certo costituire una prova che si vinca al centro. Donald Trump ha comunque preso oltre settanta milioni di voti e più che l’aplomb dell’avversario è stata una crisi di rigetto nei suoi confronti a decretarne la tormentata sconfitta.
La pandemia ha fatto capire quanto siano importanti e protettive le istituzioni e quanto sia imprescindibile l’ombrello dello stato sociale. A parte la prevaricatrice minoranza dei negazionisti, la maggioranza dei cittadini del mondo sembra riacquistare fiducia nelle regole della convivenza civile.
Non ci sono reazionari da tranquillizzare ma risposte da dare. E queste non possono che essere radicali. L’ansia di non spaventare chi è già preda della paura e agitato dal risentimento non ha alcuna logica. Solo il coraggio di scelte rivoluzionarie, nel senso di totale cambiamento, può dare frutti fecondi. Non si tratta di sovvertire l’ordine costituito ma di ridare significato vero alla parola popolo, che dovremmo cominciare a declinare, come dice Papa Francesco, in senso positivo. Separare i poveri e i diseredati dagli evasori fiscali, i produttori dai rentier, i disoccupati dai lavativi, gli sfruttati dagli intrallazzatori, i contadini dagli inquinatori, le donne e i bambini dai prepotenti, gli onesti dai furbi, i commercianti dagli usurai, gli inermi e i non violenti dai bellicosi. Così si rompe lo schema della Nuova Destra che agglutina spinte diverse e inconciliabili. La risposta all’antipolitica non è la politica spicciola ma la metapolitica. Leggere nel profondo i mutamenti, percepire i bisogni e i desideri, districare i fili emotivi e irrazionali, seguire i rivoli della tradizione e della subcultura. Andare al cuore delle questioni e indicare soluzioni senza precedenti.
Se non ora, quando?
Marco Cianca