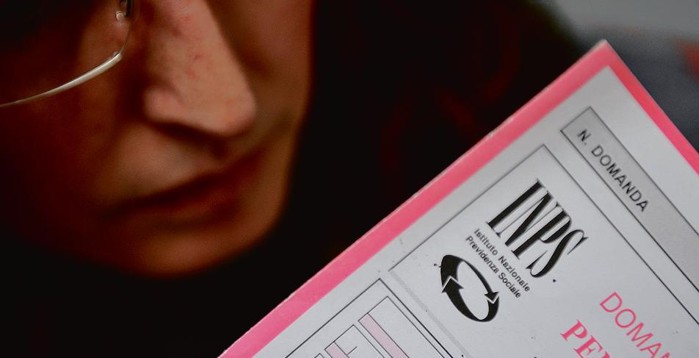Che in Italia le donne pensionate ricevano trattamenti mediamente più bassi di quelli dei loro colleghi maschi, è cosa nota. Più difficile identificare con esattezza quali siano le molteplici cause di questo fenomeno. Ancora più difficile immaginare le linee di azione che il legislatore dovrebbe seguire per raggiungere una maggiore parità nei trattamenti previdenziali di uomini e donne.
Ma adesso, sia gli studiosi di questioni previdenziali che i sindacalisti e i parlamentari interessati a questa problematica avranno a loro disposizione uno strumento in più. Si tratta di un corposo volume che è stato presentato ieri alla Camera dei Deputati e che contiene gli Atti di un’indagine conoscitiva che è stata condotta dalla commissione Lavoro della stessa Camera. Indagine che ha avuto a proprio oggetto, appunto, L’impatto in termini di genere della normativa previdenziale e le disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici.
Come si è detto, le cause che rendono mediamente più deboli le posizioni previdenziali delle ex lavoratrici rispetto a quelle dei loro colleghi maschi sono molteplici anche se, in linea di massima, possono essere ricondotte, come ha ricordato ieri il presidente della Commissione, Cesare Damiano (Pd), alla relativa maggior fragilità della presenza femminile sul mercato del lavoro.
Questa fragilità si presenta in primo luogo, a monte di qualsiasi discorso di tipo previdenziale, sotto forma di un minor tasso di partecipazione allo stesso mercato del lavoro. In parole povere, il numero di donne occupate è minore di quello degli uomini. Tanto che, come è stato ricordato da Roberto Ghiselli, segretario confederale Cgil, nel dibattito che ha fatto seguito alla presentazione della ricerca, il delta che si registra confrontando il tasso di occupazione presente in Italia con quello della media dei Paesi dell’Unione Europea può essere attribuito essenzialmente alla minor percentuale di donne occupate. Infatti, il tasso di occupazione maschile del nostro paese è vicino alla media Ue, mentre quello femminile è significativamente più basso e finisce quindi per determinare il livello meno elevato del tasso complessivo.
Lo stesso Ghiselli ha osservato, peraltro, che questa presenza meno intensa delle donne sul mercato del lavoro del nostro Paese non dipende certo da una loro minore occupabilità. Infatti, i risultati di scuole e Università ci dicono che spesso le ragazze conseguono risultati migliori di quelli dei loro colleghi maschi.
Il fatto è che il minor tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro è un sintomo di un problema più generale che si riflette poi nelle differenze dei trattamenti previdenziali cui abbiamo sopra accennato. E questo problema è essenzialmente quello del peso dei lavori di cura di tipo familiare che, come è noto, grava in misura molto maggiore sulle donne che non sugli uomini.
La prima conseguenza di questa situazione è che spesso le donne, al termine della loro carriera lavorativa, hanno alle spalle dei percorsi meno lineari di quelli degli uomini. Più spesso degli uomini, infatti, hanno avuto occupazioni intermittenti, ovvero carriere in cui periodi di lavoro si sono alternati a periodi dedicati totalmente alla cura di uno o più figli, in età giovanile, o di parenti anziani, in età più avanzata. Quindi, in sostanza, molte donne arrivano alla pensione avendo alle spalle un numero inferiore di anni in cui sono state occupate. A ciò vanno aggiunti orari inferiori, dovuti, ad esempio, al fatto che sono state costrette ad accettare collocazioni a part time che, ovviamente, danno luogo a retribuzioni mensili più basse.
Ma non basta. Infatti, anche le donne regolarmente occupate ricevono retribuzioni di fatto che, sempre in media, sono più basse di quelle dei lavoratori dell’altro sesso. Ora qui è forse necessario chiarire che nel nostro Paese le leggi prevedono, come appare peraltro ovvio, un’assoluta parità retributiva per lo stesso lavoro, indipendentemente dal fatto che sia compiuto da un uomo o da una donna. Nei fatti però le cose non stanno così. E ciò accade non perché sia stato deciso da qualcuno in una qualche circostanza, ma, appunto, per una somma di fattori quali il minor numero di ore mensili o annue lavorate, il più basso accumulo, a fine mese, di ore di lavoro festivo, semifestivo o straordinario, nonché, soprattutto, la collocazione delle lavoratrici in livelli mediamente più bassi dell’inquadramento professionale.
In pratica, alla fine della sua carriera lavorativa una lavoratrice ha ricevuto un montante retributivo mediamente più basso di quello percepito da un lavoratore e ha quindi accumulato una quantità mediamente inferiore di versamenti previdenziali. Da tutto ciò non può che derivare un trattamento pensionistico inferiore.
Nel documento conclusivo dell’indagine ieri presentata si può quindi leggere che, nel periodo 2004-2013, il “differenziale a sfavore delle donne” è sì diminuito, ma si è attestato, alla fine del periodo considerato, su un 65,7 per cento “per quanto riguarda gli importi medi delle singole prestazioni di vecchiaia”. Insomma, la pensione di una donna, in media, raggiunge a stento i due terzi di quella di un uomo.
Sorge qui l’antico interrogativo: che fare per, almeno, ridurre questo differenziale così consistente? Nel suo intervento, l’on. Marialuisa Gnecchi, capogruppo Pd in commissione Lavoro, ha sostenuto che la XVI legislatura (2008-2013) è stata, per ciò che riguarda la materia pensionistica, una “legislatura contro le donne” e che quindi la XVII legislatura, quella ancora in corso, ha dovuto porsi il problema della “riduzione del danno”, ovvero di ridurre almeno in parte i danni fatti con la riforma che porta il nome del ministro Fornero. Anche se l’on. Gnecchi preferisce parlare di “manovra Monti-Fornero”, visto che il capo del Governo, in cui la professoressa Elsa Fornero era ministro del Lavoro, è stato il professor Mario Monti.
Secondo l’on. Gnecchi, questi danni non hanno fatto altro che peggiorare una situazione già compromessa nel 2009, sotto il quarto governo Berlusconi, dalla capziosa interpretazione di una sentenza della Corte di giustizia europea in materia di parità previdenziale fra uomini e donne. Interpretazione che aveva portato a cancellare il diritto delle donne del pubblico impiego ad andare in pensione di vecchiaia in tempi anticipati rispetto a quelli degli uomini. Infatti, sempre secondo l’on. Gnecchi, questo diritto costituiva, in sostanza, una forma di compensazione degli svantaggi sopra citati. Aver equiparato i tempi del pensionamento di vecchiaia ha quindi colpito un aspetto fondamentale dei diritti previdenziali delle lavoratrici senza che fosse stato prima posto riparo ai motivi che le ponevano in una condizione svantaggiata. La manovra Monti-Fornero, con il “brusco innalzamento” dei requisiti anagrafici necessari per conseguire la pensione di vecchiaia, ha finito poi per costringere molte lavoratrici o a rivedere radicalmente i propri progetti di vita, prolungando l’impegno lavorativo oltre il desiderabile, o a subire lunghi periodi di disoccupazione prima del raggiungimento dell’età utile per poter andare in pensione.
Il pensiero dell’on. Gnecchi, che si è impegnata con grande determinazione per condurre in porto l’indagine di cui stiamo parlando, può dunque essere così riassunto: da un punto di vista previdenziale, “le donne sono in credito”. Che fare dunque per dare alle donne ciò che è loro dovuto in termini pensionistici?
In primo luogo, si può leggere nel documento approvato dalla Commissione a conclusione dell’indagine, occorre valorizzare “tutti gli istituti capaci di ridurre gli effetti negativi della maggiore discontinuità delle carriere lavorative femminili”. A tal fine, prosegue il documento, “appare opportuno incrementare i benefici (accrediti figurativi, aumenti dell’importo pensionistico, facoltà di riscatto) in relazione a specifici eventi (quali la nascita e la malattia dei figli, l’assistenza a disabili e ad anziani non autosufficienti)”. E ciò “soprattutto al fine di estenderli anche ai periodi al di fuori del rapporto di lavoro”; ovvero a periodi “rispetto ai quali la legislazione italiana risulta comparativamente più carente in confronto a quelle degli altri Paesi europei”.
Oltre a ciò, allo scopo di incrementare i trattamenti pensionistici delle lavoratrici, “si potrebbe tener conto, ai fini del calcolo contributivo, non già dell’intero ciclo di vita lavorativa, ma solo degli anni meglio remunerati”, in modo da evitare quelli a salario zero o a basso salario – dedicati, in tutto o in parte, ai lavori di cura – finiscano per abbassare l’importo della pensione.
Infine, si impone “una riflessione più ampia”che comprenda per intero la “condizione lavorativa delle giovani generazioni” in rapporto alle loro, difficili, prospettive previdenziali.
Insomma, idee e suggerimenti non mancano. E tutto ciò può avere un’utilità anche più ravvicinata di quanto non si possa credere, solo che si tenga conto del fatto che, come ha ricordato nel suo intervento il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, è attualmente aperta la cosiddetta “Fase 2” della trattativa in corso fra Governo e sindacati su una rivisitazione del nostro sistema previdenziale che appare sempre più necessaria.
@Fernando_Liuzzi